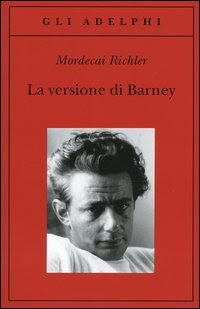Inizio dalla prima volta che ci siamo visti. Estate. Ero all’Auchan per una spesa veloce, per quanto possa essere veloce una spesa con migliaia di oggetti che ti ammiccano dagli scaffali cercando di attirare la tua attenzione e un fiume di gente in piena che ti travolge portandoti in giro fra le rapide. Per fortuna lì c’è sempre un luogo semideserto, popolato solo da creature perse che si danno appuntamento dove è meno affollato: quello dei libri. Aspettate. Prima devo spiegare una cosa: un fenomeno strano che si verifica tutte le estati è la misteriosa comparsa di ondate di libri sugli scaffali, solitamente deserti negli altri periodi dell’anno. E tutti gli anni, a luglio, mi ritrovo a curiosare tra titoli stranoti, titoli à la page, come quest’anno le opere di Doris Lessing, Nobel del 2007, e titoli sconosciuti di autori ancor più sconosciuti, almeno a me.
E’ proprio tra gli autori meno noti che ho imparato ad apprezzare le opere di Antonia Byatt e Koetzee perciò ci do sempre un’occhiata.
Ad altezza occhi trovo proprio Doris Lessing e il suo libro sui gatti, un po’ più in alto Joseph Roth, che io confondo con Philip Roth e metto in fretta nel cestino. Impiccato in alto un certo Mordecai Richler mi fa l’occhiolino, sono in vena di shopping, prendo anche lui, vado con il mio bottino alla cassa e torno a casa. Ripongo tutti e tre, e altri dei quali non ho accennato, su una piccola libreria all’ingresso così divisa: sopra una foto che ci sta sempre bene, primo ripiano i libri di prossima lettura, secondo ripiano i libri appena letti che sono troppo pigra per riporre con cura nello studio, ripiano in basso le uscite di “Invito all’Opera”.
La settimana scorsa Mordecai mi ha di nuovo strizzato l’occhio e l’ho infilato in borsa per leggermelo con comodo durante la pausa pranzo sotto il mio ulivo (approfitto del bel tempo finché si può), porto con me anche un Victor Hugo nel caso quello che legga non mi piaccia.
E invece mi piace.
Hugo torna la sera stessa sulla libreria.
La foto in copertina mostra un uomo sui trent’anni spaventosamente somigliante a James Dean, non c’entra nulla con il libro: è una foto dell’autore scattata probabilmente negli anni 50-60.
Nel primo capitolo l’autore cerca di spiegare lo scopo del libro ma ci riesce a pieno solo durante la narrazione, Barney, produttore televisivo canadese prossimo alla settantina, racconta la sua vita a partire dal momento del distacco dalla famiglia e lo fa dandone, ovviemnte, la sua versione.
Ha vissuto, negli anni ’50, un periodo bohémien a Parigi, circondato da amici con mire letterarie, alcuni dei quali hanno avuto successo e vedono le loro opere esposte oggi, gli anni ’90, in varie librerie. Uno di questi, nella sua ultima fatica, ha scritto proprio di quella ghenga, così la chiama Barney, di giovani canadesi a Parigi. L’immagine che ne esce di Barney è orribile, miserevole direi. La versione di Barney è una vendetta: nei confronti dell’amico scrittore, nei confronti della società che lo ha visto imputato in un caso di omicidio ancora irrisolto, per il quale molte delle sue conoscenze lo ritengono colpevole, nei confronti di se stesso, perché è riuscito a rovinare qualsiasi cosa abbia avuto tra le mani.
Non c’è apologia, tutto è raccontato nei più beceri aspetti, la vita bohémienne di Parigi non è rivestita di quella patina romantica che ci si potrebbe aspettare: la narrazione è triviale, bassa, il suo primo matrimonio viene descritto come una fatalità inevitabile per riparare alla gravidanza della sua amichetta e il bambino che ne nasce, senza vita, non è nemmeno suo, ma Barney confessa di essersene accorto solo nel momento in cui lo ha visto, troppo scuro per essere il figlio di due ebrei canadesi.
Il secondo matrimonio non è certo meglio: involontariamente si trova a dire “lo voglio” e non si capisce nemmeno perché. Quello che si capisce è che lei potrebbe essere perfetta, per altri, non per lui, lui è quanto di più distante dalla perfezione.
Mentre leggo non mi accorgo che le pagine scorrono velocemente, saranno le storie di inverosimile quotidianità, sarà quel tono canzonatorio dell’autore nei confronti di se stesso, saranno quei discorsi bassi, talmente reali, talmente intimi, che un uomo farebbe a stento anche con se stesso.
E’ il racconto di un vecchio che cerca di sopravvivere alla quotidianità dei nomi di oggetti che non gli vengono in mente, ricorsivamente ripete una sorta di mantra che gli serve per dimostrare a se stesso di non essere decrepito: l’aggeggio che serve per versare la minestra, i nomi dei sette nani, associazioni di nomi di autori e opere scritte. Quando non ci riesce dice sarcasticamente “chi se ne frega”, quando pensa di esserci riuscito fa “tiè!”, quasi avesse vinto una partita che sta giocando da solo.
E’ il racconto di un vecchio che non si vergogna di descrivere la sua visita dal proctologo, non si vergogna di menzionare le incontrollate e rumorose reazioni del suo intestino a cena con una squillo.
Barney è un uomo solo che è riuscito a distruggere ogni cosa nella sua vita, ha distrutto tutto perché ha sempre denigrato tutto, per primo se stesso. Ma ama la sua famiglia, la vede attorno a sé anche se i figli hanno ormai lasciato il nido e Miriam, la terza moglie, lo ha lasciato per mettersi con un “professorone-vegetariano-salviamo-le-balene-niente-pelliccia-per-favore”. Si aggira solo per casa, accarezza la sedia a dondolo sulla quale Miriam allattava i figli, fruga tra i libri, gli sci, le racchette dei suoi bambini… è talmente reale il suo narrare che ti viene di girarti e dire “Piantala di muoverti alla rinfusa, mi dai fastidio!”. Durante tutta la narrazione sempre lo stesso intercalare: “Miriam, mia Miriam”, la vede ovunque e le dice “Sei bellissima, Miriam”, bellissima a vent’anni quando l’ha vista per la prima volta al suo proprio secondo matrimonio e, dopo aver detto sì, l’ha rincorsa per chiederle di fuggire a Parigi, bellissima al primo appuntamento dove lui ha vomitato per tutto il tempo, bellissima arrabbiata, bellissima a sessant’anni, all’ultimo appuntamento, poco dopo aver scoperto di soffrire di Alzheimer, prima di non ricordarla più.
L’ultimo incontro non appartiene già più alla versione di Barney: Barney ha già finito di ricordare, a proseguire il racconto è uno dei suoi figli, Saul, che, con l’amore e con l’odio che accompagna il rapporto padre-figlio, cerca di ricostruire gli ultimi giorni del padre, troppo tardi per amarlo, troppo presto per comprenderlo, troppo tardi anche per dargli ragione lì dove tutti, amici e parenti, gli avevano dato del bugiardo. Le ultime due pagine mi fanno balzare in piedi, con una mano tengo il libro, con l’altra incito Michael a “vedere” la realtà di fronte i suoi occhi, stringo il pugno e urlo: “Ma non vedi, pezzo d’idiota? Non capisci?”. Alla fine comprende, comprendiamo tutti.